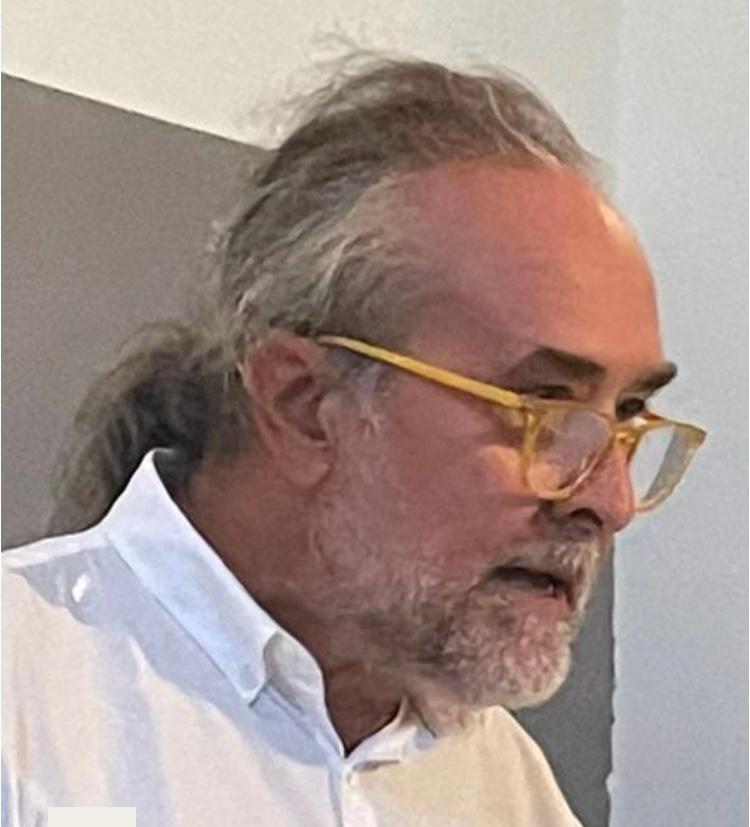di Maurizio Muragliastereotipando
Le buone pratiche
Giuro. É un costrutto che ho usato decine di volte. Di più. Lo uso ancora e confesso di non poterne fare a meno. Ma più passa il tempo più sento che qualcosa in questo costrutto è a rischio di usura. Come tanti altri detti dello scuolese diffuso, anche le cosiddette “buone pratiche” rischiano di suscitare più interrogativi di quanti ne risolvano, e quando questo accade vuol dire che stanno per diventare il comodo involucro di qualcosa che non ha consistenza semantica. Private di un contenuto comprensibile e condivisibile, le buone pratiche rischiano la stereotipia, ovvero la collocazione nello spazio del chiacchiericcio scolastico di maniera. In questi casi, occorre visitare lo stereotipo. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa io stesso vado parlando, quando parlo di buone pratiche? Per la prima volta, Stereotipando ha a che fare con l’autoanalisi. Chi scrive non riesce a prendere le distanze dallo stereotipo, vi resta semanticamente invischiato e tuttavia azzarda il colpo di coda della destereotipia. Partendo, come sempre, dall’analisi delle parole.
Primo: “pratiche” (dunque non teorie). Secondo: “buone” (dunque non cattive).
Quando parliamo, parlate, parlano, parlo di “buone pratiche” a scuola ci si riferisce sempre a qualcuno che insegna e a qualcuno che impara. La scuola è una comunità di pratiche perché chi vi opera non specula in astratto ma entra in azione, esercita la volontà, dà forma organizzativa alle proprie idee. Insegnare è una cosa altamente pratica, oggi si direbbe, “performativa”. Avviene tutte le mattine in varie forme, quando si spiega, quando si assegna un compito, quando si interroga e si valuta, e tutto questo richiede chi fa cosa, e questo fare è un fare su cui si può riflettere e che si può raccontare. Il fare riflessivo è professione, il fare irriflesso è mera esecutività, questo è vero, ma ogni lavoro in fondo è vedere all’opera homo sapiens che si configura quale homo faber e pertanto la circostanza che si parli di pratiche a proposito del cosiddetto “fare scuola” non rappresenta nulla di diverso da altro genere di pratiche, da quelle dell’architetto, del medico, del bancario, dell’imbianchino, dell’elettricista. Si tratta anche lì di pratiche. Persino la “testa ben fatta” di Michel de Montaigne è il risultato di una pratica.
La prima questione dunque appare pacifica. La scuola è questione di pratiche, qualsiasi cosa si faccia in classe. É la seconda questione che apre un mondo più complesso di significati: la questione delle pratiche “buone”. Con tutta evidenza l’attributo “buone” è di ordine valutativo. Suppone il suo contrario ed è proprio la tensione valutativa tra buono e cattivo di fronte a una pratica scolastica che spalanca un oceano di discorsi, di riflessioni, di strategie, di politiche. Chi non premierebbe una buona pratica? Chi, di fronte, a un fare… ben fatto, non sarebbe tentato di dire: “Ma perché non facciamo tutti così?” Ed è forse per questo che il costrutto ha preso piede negli anni, insieme all’idea della “disseminazione”: perché si è pensato, si pensa, e io che scrivo certamente (forse) ancora penso che se una cosa riesce bene sarebbe il caso di riprodurla da qualche altra parte. Persino ai progetti PON finanziati dai fondi strutturali e orientati alla formazione dei ragazzi si chiede la costruzione dei cosiddetti “prototipi” ovvero di quei protocolli di intervento, estrapolati da azioni reali, che consentano la riproducibilità di un’azione in altri contesti. É una forma di scientificità applicata all’insegnamento.
Dunque una pratica didattica perché abbia fortuna in luoghi diversi da quelli in cui è stata concepita dovrebbe essere “buona”. E come se ne stabilisce la bontà? Quali indicatori la suggeriscono? Il campo della medicina qui può venire in soccorso. Una terapia è valida per ogni tipo di paziente? Se un certo trattamento farmacologico si è rivelato “buono” in uno o più casi, vorrà dire che dovrà essere considerato “buono” in assoluto? I medici conoscono bene tali questioni. E sanno ragionare in termini di probabilità. La ricerca li sostiene perché fornisce loro le statistiche di successo e gli informatori farmaceutici girano in lungo e in largo gli ospedali per raccomandare i farmaci delle aziende per cui lavorano. Un po’ come i rappresentanti editoriali.
Ma a scuola quanto di tutto questo è praticabile? Qualcosa probabilmente sì, ma anche a scuola occorrerebbe costruire una cultura della documentazione delle pratiche, fatta di processi e risultati. Cosa ci farà dire che una pratica didattica è risultata “buona”? Il clima creato in classe? La motivazione ad apprendere? I risultati di prove strutturate? I risultati di prove qualitative? La persistenza nel tempo degli apprendimenti? O ancora altro? Forse tutto questo e ancora altro. E tutto questo e ancora altro andrebbe rilevato, documentato. Da chi e quando? Fermiamoci un momento.
A scuola esistono i cultori della programmazione, che preparano a tavolino nei minimi particolari tutto quanto faranno in classe, e i cultori del progress, che cercano di adattare gli interventi a quanto via via va emergendo dal “clima della classe”. Tra i due estremi una vasta gamma di atteggiamenti orientati quale più quale meno verso l’una o l’altra polarità. Bisognerebbe che tutti gli insegnanti disponessero della stessa griglia di osservazione delle pratiche da essi stessi realizzate e che al termine di un lavoro facessero un lavoro di auto-documentazione che, in quanto “auto”, finirebbe per essere alquanto autoreferenziale. Ma se non lo facessero loro chi dovrebbe farlo? E quando? Nodi seri, che se irrisolti rendono le pratiche alquanto evanescenti. Le pratiche… accadono. Chissà se sono “buone”. Alle volte si riesce a documentare, a pubblicizzare. Quante pubblicazioni raccontano di buone pratiche? E quando le hai lette ti resta comunque l’interrogativo, anzi almeno due interrogativi. Primo: e che risultati ha ottenuto questa pratica? Secondo: ma io potrei fare una cosa simile? E si finisce per lodare la buona pratica ritenendola buona per una sorta di rispetto generico: in fondo ha lavorato con coscienza, ha documentato, ma… chi ha visto effettivamente quel che è avvenuto?
Buone pratiche. E chi potrà parlare delle cattive pratiche? C’è un criterio per valutare come “cattiva” una pratica? Impresa folle. Chi può cimentarsi senza scatenare un diluvio di insulti? Come osi dire che una certa pratica è “cattiva”? Chi si azzarda, nei consigli di classe, a dire qualcosa di simile a un collega? Eppure chi parla di buone pratiche implicitamente conosce anche le cattive pratiche. Solo chi conosce le cattive pratiche può parlare di buone pratiche. Ma l’omertà qui si impone. Quell’omertà che aleggia quando si fa un serio discorso sul merito. Un serio discorso sul merito? Sì, anche qui chi scrive “serio” suppone che ci sia un discorso sul merito che è il contrario di un discorso serio. Un discorso sul merito avrà a che fare con le buone pratiche o no? Oppure ha a che fare con la quantità di tempo trascorso a scuola, sulle “competenze” messe a disposizione della scuola (lingua e informatica?), sugli incarichi di coordinamento assunti o su altre questioni serissime che però non toccano il tema delle buone pratiche ovvero il tema principe dell’essere insegnanti? E i buoni risultati dei ragazzi nei test Invalsi suppongono “buone pratiche”? É una buona pratica il teaching to test? É una buona pratica testificare il sapere? Chi può dirlo?
Dunque l’invischiamento semantico è avvenuto. Non ci si capisce più niente, o meglio si capisce troppo bene che chi parla di merito sa che ci sono insegnanti “meritevoli”, ma fa fatica a capire quali “pratiche” li rendano meritevoli. E perché fa fatica? Perché forse si è perso di vista cosa vuol dire insegnare bene e cosa vuol dire apprendere bene. E soprattutto cosa vuol dire “bene” a seconda dei contesti. Ma le idee sull’insegnare e le idee sull’apprendere hanno perso appeal perché sono idee complesse e soprattutto non riducibili a dati. Una buona pratica è un dato? Si può quantificare? Mettere in graduatoria? Comparare? Probabilmente no. Estromesse dallo spazio religioso della quantificabilità le buone pratiche hanno a che fare col sentimento e in quanto tali significano tutto e nulla. Intuiamo che ci sono (o che non ci sono), le vediamo “a macchia di leopardo”, ma il contenuto del nostro discorso resta sfuggente, fino all’evanescenza. Finché spariranno prima l’aggettivo e poi, forse, anche il sostantivo.